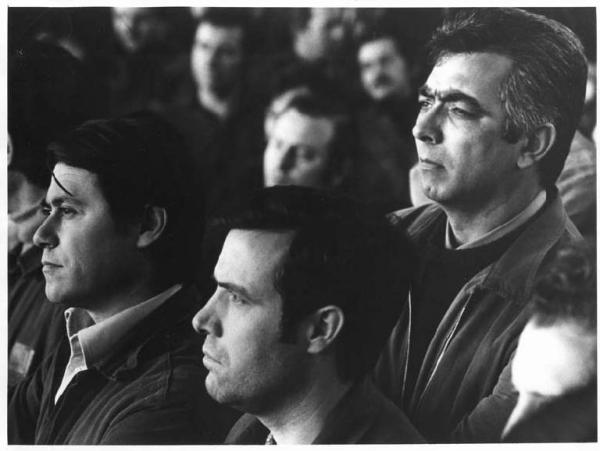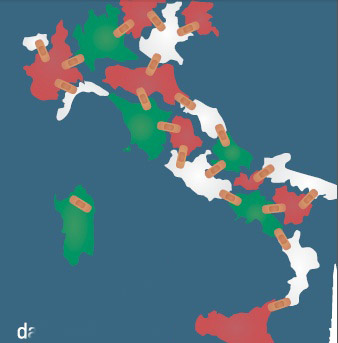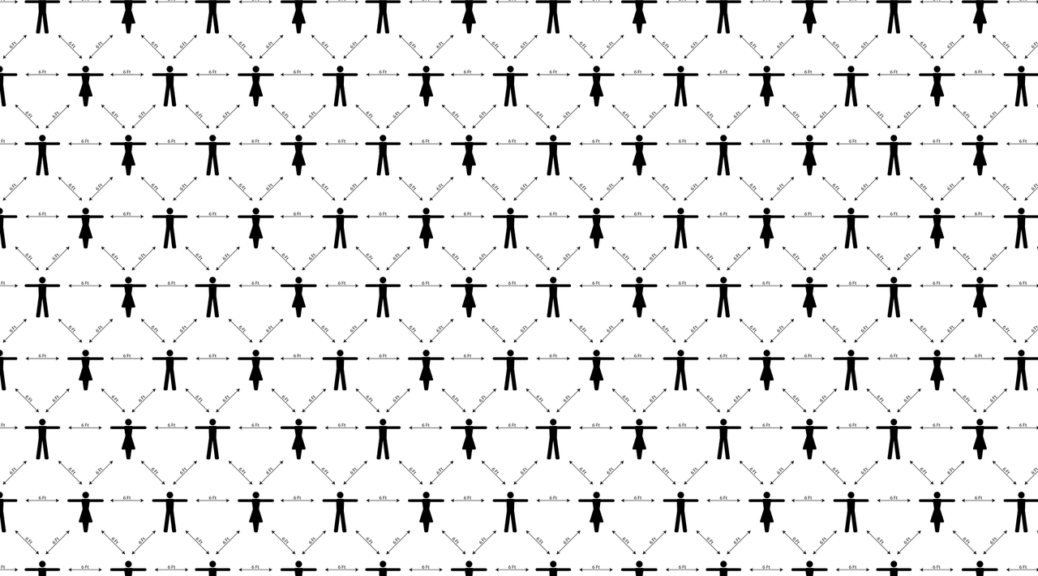I partigiani calabresi.-di Piero Bevilacqua
Un importante contributo alla storia, alla memoria civile e all’immagine pubblica della Calabria – forse la regione più gravata di stereotipi denigratori dell’intera Penisola – è appena uscito presso un editore calabrese, per merito di Pino Ippolito Armino, Storia della Calabria partigiana, Luigi Pellegrini Editore Cosenza, 2020, pp. 351.
Si tratta di un voluminoso testo di ricerca che corrisponde pienamente all’ambizione del titolo, e che innanzi tutto si fa apprezzare per la luce che getta su un aspetto poco esplorato della nostra storia, oltre che per meriti morali. Vale a dire per l’onore che rende ai tanti ignoti, o dimenticati, che pagarono con la vita la loro generosità e il loro coraggio di combattenti.
Dopo un originale saggio di storia economica comparativa, meritevole di più ampia diffusione, Quando il Sud divenne arretrato, pubblicato nel 2018, Ippolito torna ai suoi temi di storia politica con un lavoro che muove da una dichiarata intenzionalità etico-politica, come diremmo con vecchio linguaggio crociano. La illustriamo con le stesse parole dell’autore, che contengono, in breve, anche una sacrosanta rivendicazione storiografica del carattere non casuale e forzato, ma volontario e progettuale della Resistenza italiana.
Se, ricorda Ippolito, «accertato è il contributo niente affatto marginale, che i meridionali diedero alla lotta di liberazione nei venti mesi in cui l’Italia del Nord si oppose all’occupante tedesco. Se tutto questo può considerarsi ampiamente acquisito, è ancora dura a morire l’opinione che i meridionali vi parteciparono in quanto soldati sbandati, impossibilitati a far ritorno alle proprie case, in un certo senso costretti dalle circostanze a entrare nella Resistenza.
La tesi contiene elementi di verità ma non può essere considerata assorbente ed esplicativa di ogni situazione, per non cadere nella trappola di chi, con analoga semplificazione, ritiene che i partigiani settentrionali fossero in larga parte giovani che sfuggivano alla leva della Repubblica Sociale Italiana(RSI) o alla tradotta in Germania». Tesi importante che Ippolito convalida persuasivamente in 350 pagine di testo con uno sforzo documentario davvero ammirevole, portando un ulteriore contributo alla stessa storia della Resistenza italiana, oltre che al ruolo svolto dai calabresi nelle sue file.
Il libro ha un carattere sistematico e ad ampio raggio, geografico e temporale. Inizia con la Resistenza prima della resistenza, come titola il primo capitolo e ricorda i primi tentativi e i primi programmi insurrezionali nel marzo 1943 a Reggio Calabria, da parte di gruppi di operai, studenti e professionisti, seguiti più tardi da vere forme di mobilitazione armata. È quella che si svolge in seguito allo sbarco degli inglesi fra Roccella e Caulonia, sullo Jonio, e a Palmi, sul Tirreno, che vede già protagonista Pasquale Cavallaro.
Il futuro artefice della Repubblica di Caulonia. In questa area della Calabria si ha la prima vittima della lotta antitedesca. In seguito a un atto di sabotaggio, contro le armate tedesche in ritirata, a Taurianova, viene ucciso Cipriano Scarfò, socialista, fucilato dopo un rito sommario.
Comincia da qui il racconto di stragi e uccisioni in cui i calabresi hanno sempre, a diverso titolo una parte. Ancora in Calabria, i tedeschi, che il 6 settembre cannoneggiano il paese di Rizziconi, lasciando a terra 17 morti, per lo più adolescenti, e 56 feriti, si fanno esecutori della fucilazione, ad Acquappesa, di 5 giovani militari originari della piana di Gioia, che avevano abbandonato il loro reggimento, probabilmente per unirsi agli anglo-canadesi appena sbarcati, e combattere contro i tedeschi.
Dalla Calabria, secondo un ordine temporale e al tempo stesso, come abbiamo detto, geografico, da Nord a Sud, quasi a ridosso della direzione della stessa guerra, Ippolito passa alla resistenza romana. E qui troviamo in posizioni spesso di primo piano, calabresi che vivono nella capitale, da più o meno tempo, come Giuseppe Albano, originario di Gerace, noto come il Gobbo del Quarticciolo, che si batte con altri sottoproletari contro i tedeschi a Porta San Paolo. Accanto a lui una figura presente nell’immaginario di tutti noi, Teresa Talotta Gullace, immortalata da Anna Magnani in Roma città aperta, di Roberto Rossellini.
E ritroviamo anche uno studente marinaio, Ettore Arena, di Catanzaro, militante di Bandiera Rossa, una delle principali formazioni antifasciste di Roma, fucilato a 21 anni a Forte Bravetta. Arena ha ricevuto la medaglia d’oro alla memoria. Ci sono anche quattro calabresi fra i morti nel massacro alle Fosse Ardeatine, tutti esponenti della Resistenza romana, a 3 dei quali sarà conferita la medaglia d’argento al valor militare.
Con grande passione documentaria l’autore segue vicende e destini dei calabresi anche fuori d’Italia, come per quei soldati che alla data dell’8 settembre si trovavano, ad esempio, in Montenegro, Slovenia, Erzegovina, dove si sviluppò la resistenza armata. Naturalmente l’autore non si limita a inseguire i singoli casi personali di eroismo, ma racconta le vicende storiche complessive, sia che si tratti, poniamo, della tragedia di Cefalonia, in Grecia, sia della Resistenza nel Regno del Sud e poi della Resistenza nel suo nucleo armato più consistente, sulle montagne del Nord d’Italia.
In una breve recensione non è possibile dar conto analiticamente di un libro, tanto più, come in questo caso, se si tratta di un testo ricco di vicende e di eventi, alcuni peraltro poco noti, che gettano luce su una pagina drammatica e dolorosa, ancora con tanti punti oscuri, della nostra storia. Ma quel che va detto e ripetuto al lettore, è che Ippolito non si limita a ritagliare, per amore di campanile, la vicenda dei suoi tanti eroi calabresi – in appendice si contano 165 partigiani caduti, molti dei quali con rispettiva città e provincia – dalla massa dei grandi fatti storici.
Rischio che naturalmente corre chi possiede una prospettiva culturale e storiografica provinciale. Accade, in questo libro, il contrario. E cioé che dalla ricostruzione dei grandi fatti collettivi della Resistenza italiana, dall’Appennino Umbro- Marchigiano alla Valle d’Aosta, Dall’Ossola alla Valsusa, finiscono con l’emergere anche i singoli eroismi in cui spesso si consumano le vite dei giovani combattenti calabresi. Quelle vicende singole che insieme fanno la stoffa di una storia complessa, ma unitaria , su cui si fonda la nostra Repubblica.
da “il Quotidiano del Sud” del 31 maggio 2020