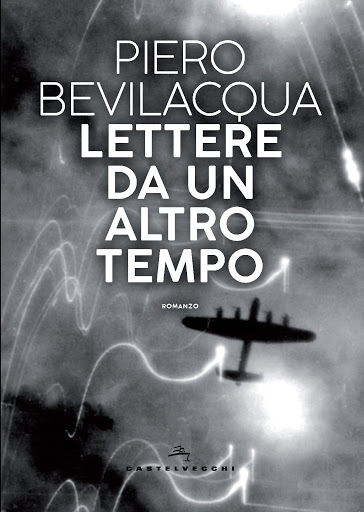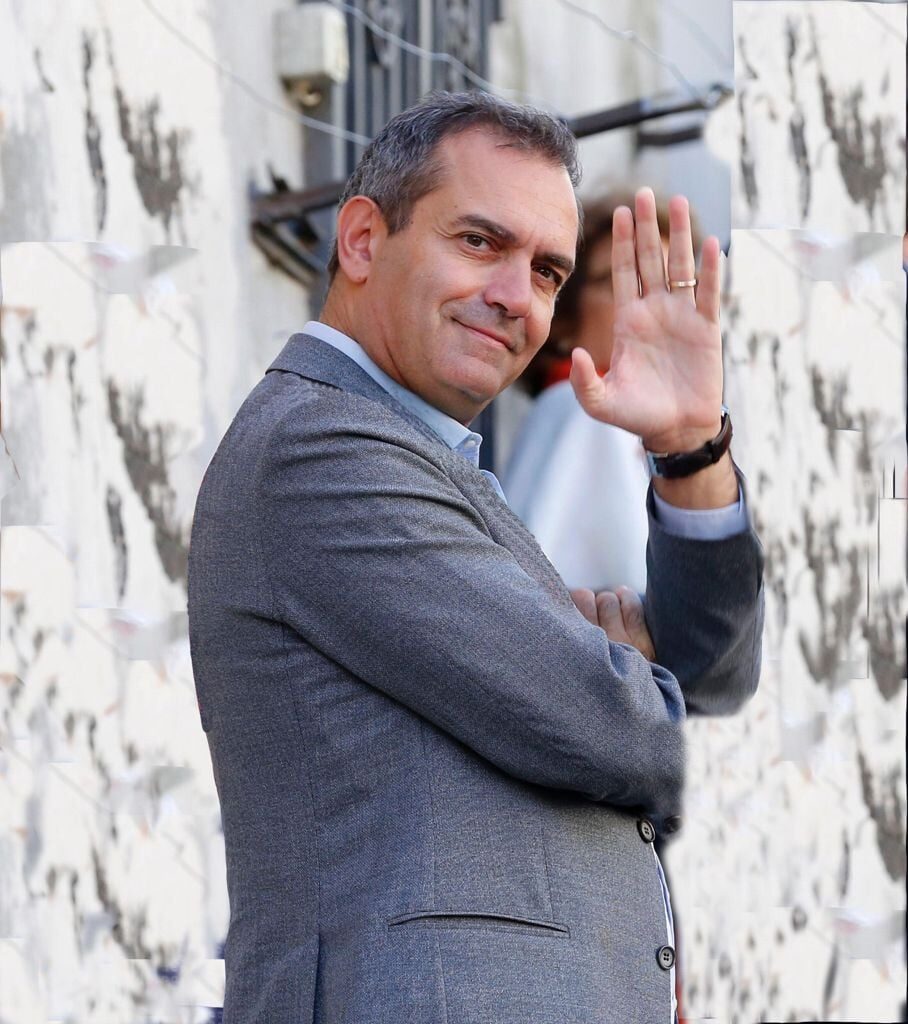
La scommessa di De Magistris nella terra più sfortunata del Paese.-di Piero Bevilacqua
Nel 1926, in un saggio per più versi geniale, Gramsci definiva il Mezzogiorno «una grande disgregazione sociale». Quell’espressione – che forse già allora sottovalutava il peso e il ruolo delle città – oggi è la definizione che meglio di tutte descrive la condizione attuale della Calabria, la regione più povera e male amministrata d’Italia. E il concetto di disgregazione consente di cogliere alcune ragioni fondative della sua condizione materiale presente e della debolezza delle sue classi dirigenti. La Calabria è già in origine una terra disgregata per la sua conformazione fisico-geografica. Non è certo un caso se per secoli, sotto il Regno di Napoli, si è avvertito il bisogno di definirla al plurale, Calabrie, e di compartirla in Calabria Citra e Ultra e poi dividerla, con ulteriore segmentazione, in Calabria Ulteriore Prima e Seconda. A differenza di quasi tutte le altre regioni del Sud non ha mai goduto di un polo aggregatore, una vera città capoluogo, in grado di connettere le sparse membra di un territorio disarticolato, difficile e disperso, in un organismo dotato di una qualche omogeneità e unità.
Reggio Calabria, la città più antica, più grande e dinamica, posta sulla punta dello stivale, era proiettata verso la Sicilia e il Mediterraneo, più che verso l’interno della regione. Mentre Catanzaro e Cosenza hanno vissuto storie separate e la prima, posta al centro del territorio, era economicamente troppo debole per svolgere funzioni egemoniche aggregative. Ricordo che negli anni ’60 e ’70, perfino il partito più coeso e unitario d’Italia, il Partito Comunista Italiano, risentiva di questa frantumazione (che comportava diversità di culture locali, legami con il passato greco o con quello latino o addirittura albanese, difformità di dialetti, tradizioni politiche, ecc) al punto che le tre Federazioni provinciali apparivano tre mondi separati.
Né questa frantumazione territoriale, sociale e politica è stata superata nel corso del secondo ‘900. L’assenza di un sviluppo economico omogeneo, ma per isole, non ha dato vita a un ceto sociale dotato di sufficiente omogeneità di caratteri, in grado di costituire l’intelaiatura unitaria che alla Calabria manca drammaticamente. Questo spiega molte cose dell’attuale disastro politico e amministrativo in cui la regione è stata inghiottita.
Una ragione evidente è che ad ogni tornata elettorale, chi ambisce a diventare presidente, non può contare su una omogenea base sociale – magari resa culturalmente autonoma da un lavoro stabile e dall’indipendenza economica – ma deve trovare accordi con la miriade dispersa dei «grandi elettori», portatori di voti raccattati nei territori, con cui mettere insieme una maggioranza.
Sicché, una volta diventato presidente, il suo compito verrà in gran parte assorbito dalla necessità di rispondere alle richieste delle varie e frantumate clientele che gli hanno consentito il successo elettorale. Mai quindi un grande progetto capace di invertire la disgregazione storica originaria, ma solo piccoli interventi di assistenza, volti a placare soprattutto, con pratiche affaristiche, la grande fame di lavoro della gioventù.
È per questo che, alcuni mesi fa, ad apertura della campagna elettorale, quando seppi che Luigi De Magistris intendeva presentarsi quale candidato, ne fui sorpreso e lieto. Non pochi calabresi, anche di sinistra, appresero la notizia con contrarietà, sentendo la candidatura come l’invasione di campo di un forestiero, come se i precedenti presidenti calabresi avessero compiuto miracoli e se ne sentisse la nostalgia.
Ora, a parte il fatto che De Magistris estraneo alla Calabria non è poi così tanto, avendovi svolto il ruolo di magistrato per alcuni anni. Ma quella «estraneità», o per meglio dire quella «esternità», costituirebbe una risorsa preziosa per il futuro del governo regionale.
La popolarità, il carisma di De Magistris, il fatto – che dovrebbe pesare nel giudizio di tutti i democratici del nostro Paese – di essere stato confermato sindaco a Napoli, la città più difficile d’Italia, dovrebbe garantirgli la possibilità di vincere la partita senza sottostare ai patti con la miriade dei grandi elettori, senza dover assecondare i loro minuti interessi, e poter governare liberamente, secondo progetti ambiziosi di trasformazione strutturale.
Un uomo esterno ai partiti (aggregati di gruppi elettorali, nel migliore dei casi), un ex magistrato in una terra funestata da illegalità e criminalità, un amministratore dotato ormai di una lunga esperienza di governo locale, sarebbe una fortuna per la Calabria.
De Magistris da mesi sta conducendo un’azione che dovrebbe costituire un modello per tutti i politici: sta battendo la regione per ascoltare chi ha da esprimere bisogni, chi è in grado di fornirgli consigli. Ricordo infine un aspetto che oggi – di fronte alla devastante prova data dalle regioni italiane in tempi di pandemia – andrebbe sottolineato, l’attiva posizione che De Magistris ha preso contro l’autonomia differenziata. Non lo hanno fatto né Emiliano né De Luca. Per questo il Partito Democratico (quello calabrese, ma anche quello nazionale) deve assumersi tutta la responsabilità di far riuscire o far fallire questa possibilità e questa speranza per la regione più sfortunata d’Italia.
da 2il Manifesto” 30 aprile 2021
foto dalla pagina fb:Luigi de Magistris Presidente per la Calabria
https://www.facebook.com/dema.calabria/photos/a.104456624317449/472593024170472